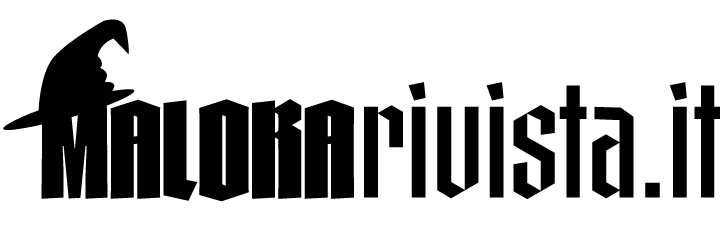Per Meltemi Editore, nella Collana Culture Radicali il nuovo libro di Rachele Borghi, Decolonialità e privilegio.
Un libro che ha l’ambizione di portare in Italia il dibattito teorico e politico del pensiero decoloniale in una prospettiva femminista. Il testo apre con una sorta di dialogo interiore tra l’autrice e bell hooks, un dialogo che prepara il terreno per uno scritto che si propone di partire da un posizionamento incarnato e dal racconto di esperienze personali e collettive, che di volta in volta si legano alla ricostruzione del quadro teorico decoloniale. Il pensiero decoloniale, che si sviluppa a partire dalla fine degli anni Ottanta principalmente in America Latina e nei Caraibi, dunque al di fuori dei centri di produzione di pensiero occidentali, si trova nel libro di Rachele Borghi collegato alla sua esperienza particolare di docenza e di ricerca in accademia, da un lato, e di attivismo queer dall’altro.
La riflessione proposta nel libro si articola attorno a due concetti principali, il primo dei quali è la decolonialità. L’autrice parte dall’assunto che la decolonizzazione, intesa come processo storico di lotta per la liberazione delle ex-colonie, non risolva una lunga serie di contraddizioni che continuano a permeare la nostra realtà (il razzismo, l’illegittimità di saperi altri rispetto al sapere scientifico occidentale, l’impossibilità di esistere come soggetto al di fuori di quello moderno-cartesiano-europeo). In questo senso, pensare in termini di decolonialità ci aiuta a capire come uscire da un processo di più lunga durata e di più profondo radicamento del colonialismo inteso strettamente come fenomeno storico.
La decolonialità secondo Rachele Borhi
Cos’è dunque la colonialità di cui parla il libro di Rachele Borghi? A partire dal problema centrale posto dal pensiero decoloniale, ovvero la relazione tra modernità, potere e capitalismo, i territori da liberare – spiega l’autrice – sono “quelli della mente, quelli dell’essere, quelli del potere”. Nel proporre questa lettura, l’autrice liquida abbastanza velocemente il pensiero postcoloniale che avrebbe avuto il limite di avanzare una critica meramente decostruttiva nei confronti delle rappresentazioni e dei discorsi che l’Europa ha costruito verso i suoi altri coloniali. Non è qui il caso di entrare nella discussione sul lungo e interessante dibattito dell’archivio postcoloniale.
Ci pare però importante ricordare come una parte considerevole degli autori postcoloniali abbia fornito analisi fondamentali sui rapporti materiali di sfruttamento e resistenza che attraverso la modernità si sono venuti a creare nell’intreccio strutturale tra razza, capitale e formazione degli stati nazione europei. Se da un lato, dunque, è indubbio che alcuni filoni della teoria postcoloniale siano più affini a esercizi di critica culturale, è altrettanto fondamentale riconoscere come buona parte di questo archivio si sia concentrato sulla materialità conflittuale delle società razzialmente strutturate. Autori come Stuart Hall, Paul Gilroy, Achille Mbembe, così come alcuni autori appartenenti al gruppo dei Subaltern Studies indiano, hanno contribuito in maniera decisiva a espandere i limiti di buona parte della teoria critica europea sul ruolo centrale e polimorfo che la razza gioca all’interno delle società coloniali e postcoloniali.
 La riflessione sul privilegio
La riflessione sul privilegio
Il secondo punto attorno a cui ruota la riflessione proposta nel libro è il privilegio, inteso come la posizione specifica occupata – spesso inconsciamente – dalle persone appartenenti a un gruppo dominante nello spazio sociale. “Avere la pelle bianca in un sistema di dominazione bianco, essere eterosessuali in un sistema in cui l’eterosessualità è considerata la norma, essere consideratie sani di mente in un sistema che patologizza ogni deviazione (…) o avere un reddito medio in un sistema-mondo in cui una persona su dieci vive condizioni di povertà estrema, non è normale e neanche evidente: è un privilegio”. Ma più di tutto, spiega l’autrice, è la neutralità ad essere un privilegio, ovvero la possibilità di dissolversi dentro a ciò che è dato per scontato, reso naturale, al punto da rendere invisibile il privilegio stesso. In questo senso, il passaggio fondamentale per agire cambiamento sociale è, secondo l’autrice, il riconoscimento (la coscientizzazione) del proprio privilegio.
A partire da questi due punti centrali, il testo spazia su temi molto vari e ha sicuramente il pregio di offrire un accesso quasi immediato a queste riflessioni. In questo senso, si tratta certamente di uno dei rari contributi che favoriscono la diffusione del pensiero decoloniale presso un pubblico italiano, non ristretto a una cerchia accademica. L’autrice, che lavora come ricercatrice presso la Sorbonne di Parigi, si pone, tra gli altri, l’obiettivo di far saltare la distinzione netta che separa la teoria scientifica dalla divulgazione, provando ad articolare una forma, un discorso e un linguaggio che non necessitino di traduzione ulteriore.

Questa capacità del libro di spaziare attraverso temi solitamente trattati in modo più specifico – ciascuno dei quali potrebbe meritare un libro a sé – va talvolta a scapito della precisione e dell’approfondimento in alcuni passaggi. Tuttavia non tradisce quello che pare essere l’obiettivo di presentare queste riflessioni e di renderle fin da subito pensabili nella pratica. In effetti, l’impianto dichiaratamente manualistico del libro – pillole, manuale, bignamino, atelier, kit di montaggio, esercizi – mira a tradurre in modo pratico riflessioni teoriche ampie. Questo è sicuramente un lavoro necessario e un merito del libro di Rachele Borghi, che ci permette in questo modo di calare nella realtà strumenti teorici di cui abbiamo bisogno.
D’altro canto, il manuale di istruzioni ha insito in sé il rischio di risultare didascalico, come se le questioni complesse di cui il libro tratta potessero veramente essere risolte con un ricettario pronto all’uso. Una tensione simile riguarda il linguaggio. Da un lato è vero che il linguaggio usato nel libro è accessibile, in linea con l’idea di superare la lingua escludente e “disciplinante delle discipline”, come la critica epistemologica del pensiero decoloniale suggerisce. Dall’altro, il tono di voce volutamente provocatorio che emerge dalla lettura del testo maschera un carattere che a tratti può suonare normativo. Lo stesso testo che parla di pluriversalità come della necessità di un “arcipelago di punti di enunciazione” lo fa con un linguaggio che risulta talvolta direttivo, quasi a voler indicare una strada da dover intraprendere, anziché da costruire.
Conclusione
Alla fine del libro non ci resta che aprire una riflessione su queste questioni a partire da esperienze quanto più possibile collettive e calate nella complessità dei contesti specifici. Abbiamo anche bisogno che siano le realtà collettive stesse, che hanno sperimentato queste riflessioni e queste pratiche magari anche sbagliando, a condividere le riformulazioni specifiche che il pensiero decoloniale ha assunto all’interno dei diversi contesti, che non si limitino all’alveo dell’accademia.
Rachele Borghi, insieme ad altri colleghi e colleghe delle università francesi, è stata di recente al centro di preoccupanti attacchi in particolare da parte della ministra francese per l’educazione superiore, la ricerca e l’innovazione Frédérique Vidal che ha preso di mira gli studi decoloniali, di genere e intersezionali mettendone in discussione la legittimità scientifica, in particolare per quanto riguarda le ricerche su razzismo, islamofobia, sessualità e genere. In merito a queste posizioni lo stesso Centro Nazionale della Ricerca Scientifica Francese si è espresso condannandole come lesive della libertà accademica e di ricerca. Cogliamo questa occasione per esprimere la nostra solidarietà a Rachele Borghi e alle sue colleghe e colleghi.