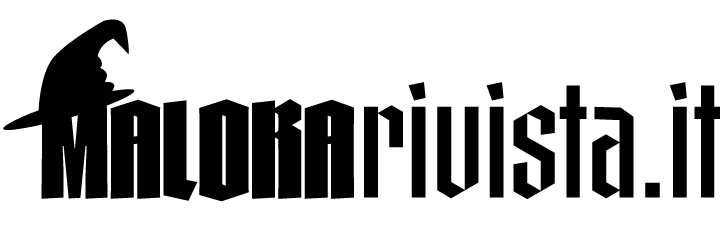Giovanni Semi, professore di sociologia urbana all’Università di Torino, presenta il suo ultimo libro, satirico e pungente sulle città giuste
“Bdsg” è un libro molto diverso dalle tue ricerche precedenti. E’ un testo satirico e polemico che si prende gioco della retorica gentrificatrice. Perché hai fatto questa scelta?
“Il mio primo libro sul tema è uscito nel 2015 e in questi anni ho girato molto. Il libro ha contribuito a sviluppare la discussione in Italia intorno alla gentrification, però quel tipo di argomentazione è rimasta su un livello accademico, sfiorando solo talvolta delle arene politiche. E nonostante vi fossero anche in quel libro molti accenni polemici, sono stati letti come una posizione personale dell’autore e quindi accettati in quel contesto accademico. Sono cioè rimasti in un limbo. Nel frattempo la macchina della gentrification spinta dalle partnership pubblico-privato, che può contare sul privato sociale, sul terzo settore, ha continuato a lavorare. E molto spesso è stata portata avanti dalle stesse persone che hanno letto e condiviso ciò che c’era scritto nel mio primo libro. In pratica, con una mano dicono che la gentrification non è una buona cosa, con l’altra la portano avanti insieme alle fondazioni. Constatato che non c’era molto da fare, ho scelto di mettere tutto questo in parodia, portando all’eccesso alcune dinamiche che sono osservabili da chiunque”.
Leggendo il volume si ha una sorta di fastidio proprio per la scelta di spingere all’eccesso retoriche che assumiamo quotidianamente e consideriamo neutre.
“Nella postfazione dico perché l’ho fatto, ed è una parte del libro a me molto cara. Dopo aver “scherzato” provo a essere molto onesto, chiarendo a chi è rivolto e perché ho scelto di usare quei toni. Per me l’importante era che il libro non lasciasse indifferenti”.
Entrando nel merito di quanto scrivi, mi interesserebbe affrontare alcune “parole chiave” ormai comuni nel dibattito politico. Slogan seducenti, che affascinano e sintetizzano un’idea di sviluppo urbano a cui in apparenza è difficile opporsi. Partirei con il tema della “città dei 15 minuti”, un concetto nato a Parigi da un professore della Sorbona e sbarcato in molte città italiane.
“Queste parole chiave fanno parte di una galassia di descrittori, che prendo di mira anche nel mio libro: la democrazia, la bellezza, lo smart, il green etc. Sono un insieme di descrittori per definizione post-politici perché nessuno si può opporre a una città in cui a 15 minuti hai tutti i servizi di cui hai bisogno, così come nessuno si oppone a una città più bella, più tecnologicamente avanzata o sostenibile o partecipata. Il punto è che non abbiamo bisogno di questa retorica: sapevamo anche prima che nascesse questo termine che abbiamo bisogno di servizi locali a disposizione, economici, aperti, che non comportino delle difficoltà di accesso. Sono cose talmente note nel lessico novecentesco che tutte le politiche urbane e di servizi pubblici che sono state fatte dagli anni Venti in poi, quindi anche dai regimi totalitari, andavano esattamente in quella direzione. La prima cosa che facevano i regimi socialisti e in generale tutti gli Stati avanzati, compresi quelli dittatoriali, erano scuole diffuse, impianti sportivi diffusi, decentramento delle attività dello Stato, perché i cittadini avessero tutto a disposizione. L’ossatura del servizio pubblico europeo è nata attorno agli anni Venti e Trenta, si è diffusa fino agli anni Settanta, e nessuno in quel contesto aveva bisogno di parlare di smart, green etc. Tutti erano consapevoli che non puoi sviluppare un’area urbana senza infrastrutturarla”.
“Questi descrittori servono a coprire una serie di politiche che vanno in direzione completamente opposta. Quando ti dico che faccio la città dei 15 minuti è perché sto pensando a aree residenziali ricche dove cercherò di decentrare attività e servizi, ma nel resto della città non applico la stessa logica. E infatti gli impianti sportivi, le scuole, la mobilità pubblica, collassano. Se andiamo a vedere da dove iniziano queste politiche, rileviamo che partono sempre dal centro, per poi arrivare, chissà quando, in periferia. L’impressione è che questa galassia di descrittori post-politici serva solamente a coprire ideologicamente delle operazioni neoliberali. La domanda che dobbiamo porci è una: che cosa vogliamo fare quando interveniamo sul corpo urbano? Vogliamo abbellire la città o vogliamo ridurre le diseguaglianze? Questa credo sia l’unica domanda da fare. Poi possiamo discutere di come rendere la città più bella una volta che è diventata più giusta, e dal mio punto di vista se è più giusta è anche più bella. Ma la verità è che gran parte di questa retorica è solo rivolta a una città più bella”.
Un altro slogan elettorale in voga nell’ultimo anno è “sindaco della notte”. E’ un altro termine che nasconde fenomeni più complessi?
“Questa politica nasce da alcune scelte del passato con cui non si è fatto i conti. Ad esempio, avendo fatto chiudere tutte le sale da ballo e le discoteche abbiamo fatto morire tutto il settore che fino agli anni Novanta era fiorente. Questo settore aveva lo svantaggio di generare problemi di ordine pubblico esterni alla città, ma aveva il vantaggio di svuotare la città di centinaia di giovani che il fine settimana si spostavano in quei luoghi. Chiuse le discoteche i giovani rimangono e in una situazione in cui la disoccupazione di massa aumenta. Abbiamo dunque masse di popolazione giovanile che non sanno cosa fare della propria vita. A ciò si è aggiunta la scelta di creare una movida nei centri delle città, con l’apertura di molti locali. Il sindaco della notte risponde a questa dinamica”.
Quindi è una risposta marginale a un effetto perverso delle politiche urbane degli ultimi anni.
“Esatto. La politica si è completamente ritirata, perché c’è un’eccedenza del sociale ormai incontrollabile, che ha invaso attraverso i consumi lo spazio urbano. Lo Stato ha scelto di liberalizzare le licenze, ma dall’altro lato non ha la forza di controllare il meccanismo e quindi fa questa cosa tipicamente neoliberale: concede spazi di mercato e contemporaneamente non concede nessun controllo ex-post, lasciando che siano i cittadini a regolarsi tra di loro. Uno Stato novecentesco concederebbe un terzo delle licenze, ma siccome in questo caso è l’Unione Europea che le ha liberalizzate, lo Stato si riduce all’uso di altri strumenti, come la leva fiscale, chiudendo per dei periodi i locali, scaricando sui gestori un fenomeno che le istituzioni non sanno gestire”.
In questa retorica si dissolvono disuguaglianze e conflitti, scompaiono le fasce di popolazione più svantaggiate.
“Qui torna il tema della bellezza, che citavo e che è un punto cardine del mio ultimo libro. Una cosa che risulta inaccettabile nel nostro periodo storico è l’idea di degrado, di poter vedere delle figure sociali che ci disturbano: che sono colorate, puzzolenti, fastidiose e che fanno tutto quello che non si deve fare. In passato non c’era una tolleranza elevata, ma c’era una quotidianità, nelle città si vedevano i poveri. Oggi li decodifichiamo in due modi: da una parte con una lente razzializzante, come immigrati, e generalmente di colore, che vorremmo nascondere; dall’altra come persone che fanno cose per noi inaccettabili, come dormire sotto i portici. E’ un tema che fa impazzire di rabbia tutti i cittadini benpensanti, da destra a sinistra. E’ l’inaccettabilità della visibilità dei poveri. Quindi le politiche si adeguano a questo: li occultano, li nascondono, li spostano e pensano che una volta che si sia nascosto, il problema non ci sia più. Ma le statistiche ci dicono che il numero di poveri aumenta di anno in anno. Non si potrà nascondere questo fenomeno per sempre”.